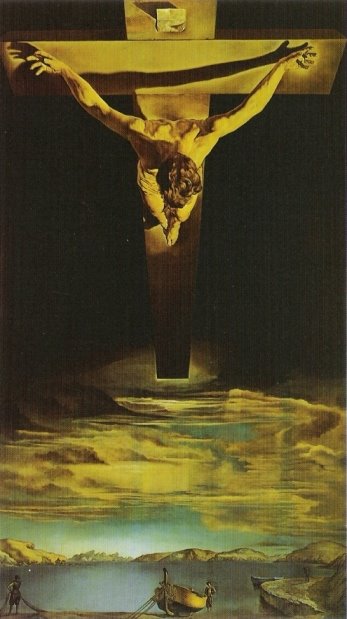mercoledì 8 ottobre 2014
IL NOSTRO TEMPO
PER IL CRISTIANESIMO
È TEMPO DI USCIRE DALL’ANGOLO
La mia ricerca teologica da tempo si muove nell’alveo del rapporto fra cristia¬nesimo e cultura contemporanea, che viene definita cultura postmoderna. Intesa come cultura diffusa, luogo dove esercitiamo la nostra libertà.
Anche il cristianesimo deve essere inteso non solo quello del Catechismo, delle encicliche, di manuali e saggi di teologia, ma soprattutto quello delle parrocchie, dei movimenti, delle associazioni, del credente di strada.
Il nostro tempo è un tempo di gradi paradossi, di grandi contraddizione!
Mai come in questo tempo sono vissuti così tanti geni teolo-gici (cattolici, protestanti, ortodossi), ma anche mai è iniziata a venir meno la capacità della chiesa di parlare alla e della vita della gente.
Non è un segreto che la fede cristiana in occidente, continui a perdere di incidenza, di provocatorietà.
E dove ancora resiste è una fede stanca, una fede senza gioia.
Che cosa dunque è successo al cristianesimo?
Che cosa ci è chie¬sto di fare per uscire da questa situazione che sembra l’avverarsi della triste profezia di Nietzsche (1844-1900) circa il monoteismo e del cristianesimo?
Intorno a queste domande ruota questa mia lezione preliminare, dove cerco di dare delle risposte che siano plausibili.
1. Che cosa ci è successo
Mi introduco con le parole di Umberto Galimberti, studioso attento alle problematiche del nostro tempo. «Gli uomini non hanno mai abitato il mondo, ma sempre e solo la descrizione che di volta in volta il mito, la religione, la filosofia, la scienza hanno dato del mondo. Una descrizione attraverso parole stabili, collocate ai confini dell’universo per la sua delimitazione e all’interno dell’universo per la sua articolazione» (L’ospite inquietante. Il nihilismo e i giovani, 2007).
Questo è il punto: l’uomo abita sempre una descrizione del mondo fatta da parole stabili, password, pilastri dell’immaginazione, punti di sutura del suo rapporto con il reale Ed è proprio la diversa scelta e composizione delle parole stabili che regge la differente descrizione del mondo, per esempio di un orientale o di un aborigeno, rispetto a quella di un occidentale.
«Basta avere almeno quarant’anni per percepire la sensazione di distacchi epocali da interi mondi di abitudini e di comportamenti perduti, e che si stanno completamente dimenticando» (Aldo Schiavone in Storia e destino, 2007).
Gli occidentali sono cambiati nelle loro abitudini e nei loro comportamenti, nel loro modo di vivere e di sognare, di amare e di viaggiare, di lavorare e di attendere alla ricerca della felicità.
Un mutamento rapido, repentino, radicale, di cui sfuggono le premesse. Tale cambiamento toglie letteralmente il fiato.
Si tratta di un vero e proprio inedito
Anche nella vita della chiesa è possibile verificare cambiamenti significativi.
Pur essendo restato dentro un ambiente che non ha dismesso i segni della cristianità passato, nella maggior parte dei cristiani si è instaurato un regime di dualità tra la vita e la fede.
La visione della fede e la preghiera non incidono più sul vissuto interiore e sul ritmo del quotidiano.
Il caso emblematico è quello dei giovani, per i quali la fede sempre più rappresenta uno stadio dell’esperienza infantile.
L’elemento religioso, quindi, pur non scomparso, assume una marginalità notevole.
Ma come è potuto accadere tutto ciò?
E così velocemente?
2. La perdita di ancoraggio e di coraggio
Come rendere ragione del cambiamento che stanno attraversando la società e la chiesa?
E’ necessario, secondo me, prendere atto che è cambiata la descrizione e, di conseguenza, il concetto di universo.
Il cristianesimo ha, da una parte, perso un ancoraggio forte che aveva trovato nelle parole stabili della precedente descrizione dell’universo occidentale e, dall’altra, non ha ancora avuto il coraggio, se non per un breve momento (il Concilio Vaticano II), di confrontarsi seriamente con le nuove convinzioni che accompagnano ogni occidentale che entra nel mondo.
Da metà ottocento, è infatti possibile constatare cinque grandi stagioni di mutazione culturale che hanno messo in discussione, una dopo l’altra, i concetti chiave, stabili e classici dell’universo.
In realtà non si tratta di un processi inediti: si tratta del risorgere delle tensioni della modernità che, a causa delle guerre di religione, erano state sopite.
La nuova configurazione del mondo si manifesta in tutta la sua forza a partire dalla rivoluzione culturale del sessantotto, la cui potenza di impatto è data proprio dalla lunga gestazione che la precede.
Essa è così spiazzante per la chiesa, che le è mancata la lucidità di agganciarsi alle nuove possibilità che i cambiamenti repentini di volta in volta offrivano.
Del resto nel sessantotto, il Concilio era già concluso.
Entriamo nei particolari.
Prima tappa.
Charles Darwin (1809-1882) sgancia la comparsa dell’uomo sulla terra dal legame con Dio. Invita a considerare l’origine della specie umana, piuttosto che in direzione dell’alto (il paradiso), in direzione della comu¬ne parentela con altri animali.
E’ un primo attacco alla cultura occidentale!
Troviamo poi la prima (1864) e la seconda Internazionale (1896), che intendono trasformare la protesta di Marx (1818-1883), «non possiamo atten¬dere il paradiso!», in programma politico.
Freud (1856-1839) riformula il concet¬to di "anima" quale centro di aggregazione energetico, spogliandolo di ogni aura trascendentale.
L’avvio di quella che normalmente viene indicata come seconda rivoluzione industriale (tra il 1856 e il 1878 e si conclude nel 1890) getta le basi per quella espansione globale del mercato, di cui oggi siamo spettatori, a volte impauriti.
In quegli anni si sviluppano, infatti, l’impresa della General Motors (1908) e quella della Ford (1903), nascono la Coca Cola (1886) e la Fiat (1899).
La terra non viene più percepita quale valle di lacrime, ma come un posto nel quale ci si può agevolmente installare.
Viene meno, sentenzia Nieztsche, il platonismo.
Viene meno un modo di vedere e vivere il mondo secondo una duplicità di piani ontologici e assiologici (il mondo eterno e vero, da una parte; il mondo finito e finto, dall’altra) che assegnava una particolare finalità alla vita umana: l’uomo, dotato di un’anima eterna, aveva nel cielo la sua patria.
Perde pertinenza immaginativa la parola "eternità", mentre assume una nuova risonanza e consistenza la "finitezza".
La ricaduta nella coscienza religiosa di queste nuove concezioni fu enorme.
Ci si chiede: come si può parlare più del destino escatologico dell’uomo, se non si sa più cosa sia l’eternità?
Quale consistenza ontologica attribuire alla realtà di Dio?
Non è più il finito a dover rendere ragione di sé rispetto all’eterno, ma esattamente il contrario.
Tuttavia la spinta alla finitezza e alla storia non è senza rilievo per il cristianesimo: quale è il volto di Dio per la rivelazione evangelica, se non quello che passa attraverso l’incarnazione del Cristo?
La seconda tappa di questa rimodulazione della cultura occidentale ha inizio nel primo decennio del Novecento. Accade che non appena il paradiso, ovvero la traduzione popolare della parola "eternità", viene messo tra parentesi, viene diluita anche la forza unificante e convergente.
Il finito appare subito come luogo di molteplicità, di possibilità infinite, di plurale.
Si colloca tra il 1905 e il 1908 una nuova stagione di rivisitazione della rappresentazione classica dell’occidente.
E’ l’epoca di Einstein (1879-1855), di Picasso (1881-1973), di Schönberg (1874-1951), di Joyce (1882-1941) e di Proust (1871-1922), di Freud (1866-1939), di Thomas Mann (1875-1955) e di Pirandello (1867-1936), di Kafka (1883-1824), che ribalta ogni primato del vincitore sul vinto, del forte sulla vittima.
E’ anche l’epoca di Kurt Gòdel (1906-1978), il quale sancisce l’impossibilità di rinvenire principi primi da cui derivare la matematica.
Cosa non dire della fenomenologia di Husserl (1859-1838) e della rinascita del pensiero ebraico dell’alterità grazie a Buber (1878-1965) e a Rosenzweig (1886-1929)?
Attraverso gli apporti di tutti costoro giunge a compimento la critica alla ragione moderna, troppo violenta, troppo autoreferenziale, e perde charme la parola "verità", al cui posto si installa il tema dell’alterità, dell’apertura e ospitalità del diverso.
La coscienza del soggetto umano non è più un luogo dove abita solo una verità, ma diventa un "parlamentino": in essa ci sono tante voci, che si sovrap¬pongono e collidono.
Non ci sfugga la portata della sfida: l’urgenza di pensare insieme alterità e verità ha portato alcuni settori della teologia a risco¬prire la forza del dogma della Trinità, dove l’unità della natura non sopprime la differenza delle persone.
Siamo solo all’inizio di un pensiero e di una prassi trinitari.
La terza tappa del viaggio che ci porta al nostro tempo è il campo di sterminio nazista di Auschwitz.
Qui nel 1942, secondo un’ipotesi di Galimberti, nasce l’epoca della tecnica, la quale si caratterizza per il fatto che la ricerca finalizzata al potenziamento di mezzi più veloci per uccidere i prigionieri segna lo sganciamento della tecnica dal diretto legame con i bisogni del soggetto umano.
Si impone l’assioma secon¬do il quale ciò che è tecnicamente sperimentabile va in ogni modo sperimentato: è l’avvio di quel processo di auto perfezionamento dei prodotti della ricerca tecnica, che prescinde dall’ambiente umano che però lo ridefinisce di continuo.
Questo modello ha avuto subito successo per i grandi cambiamenti che ha realizzato nel miglioramento delle condizioni medie della vita degli occidentali, dall’igiene alla salute, dai viaggi alle comunicazioni, ma ha anche inciso su una certa concezione del mondo e della vita umana.
Il mondo non è più un insieme di sostanze stabili e fisse, ma di relazioni; la vita non è fatto di faticose conquiste da preservare e migliorare, ma di possibilità, di occasioni.
Che cosa ne è allora, per esempio, delle leggi naturali, in un mon¬do che non riconosce più alcun elemento di stabilità alle cose e agli individui?
Qui salta in aria il primato dell’aristotelica sostanza, e con essa quello del "giusto mezzo" quale cardine delle virtù.
Non dimentichiamo, poi, la forza dirompente dell’olocausto sul livello inconscio dell’immagine di Dio.
Di fronte all’olocausto chi ha ragione: il prete che predica la creazione divina degli uomini o Darwin che dimostra la loro derivazione dalle scimmie?
Chi ha ra¬gione: il catechista che proclama la santità dell’anima oppure Freud che la diagnostica quale pura energia disponibile tanto all’eros quanto al thanatos, all’amore e alla morte?
Quale giustizia divina, quale paradiso, potrebbe risarcire le vittime di Hitler (1889-1945), di Mussolini (1883-1945) e di Stalin (1878-1953)?
Muore il Dio della morale, il Dio che fonda la morale nella paura.
Certo, viene lasciato libero lo spazio per l’annuncio del volto umano di Dio, fissato nelle parole e nella vita di Gesù, ma è una sfida, che la prassi ecclesiale spicciola fatica ancora ad assumere integralmente.
La quarta tappa del percorso è il fatidico anno del sessantotto, l’anno in cui le istanze di Nietzsche diventano pane quotidiano del cittadino medio occidentale: l’istanza della singolarità, dell’unicità, della corporeità, della musica orgiastica, della scelta, dell’autonomia del soggetto.
"Vietato vietare": ecco lo slogan del sessantotto, con il quale si attacca la tradizione culturale e morale del passato, giudicata eccessivamente irrispettosa della singolarità di ciascuno.
Ognuno è per sé. E tutti sono uguali.
Saltano in aria le forme di vita (matrimonio, paternità, maternità), i ritmi di vita (adolescenza, giovinezza, maturità), i mestieri.
Cosa non dire dell’emancipazione sessuale e sociale della donna?
Più in generale, ancora, in modo indiretto si può riconoscere in quella portentosa rivoluzione un attacco a un altro grande pilastro della tradizione cristiana e della tradizione occidentale, quello costituito dal pensiero di sant’Agostino e dalla parola "sacrificio": parola chiave, centrale nella descrizione occidentale del mondo, fino a quan¬do è rimasto un luogo della terra povero e con scarsa mobilità sociale, ovvero sino agli anni del boom economico.
La quinta tappa del viaggio che ha deciso la ristrutturazione della mentalità occidentale riguarda la crisi dell’autorità, della legge, cioè del riconoscimento del vincolo della legge quale garanzia assoluta di una convivenza pacifica.
Una decisa svolta contro il concetto di autorità può essere riscontrata:
- nella rielaborazione della Seconda guerra mondiale, dove era più l’autorità della forza che non la forza dell’autorità,
- nella lotta contro il terrorismo degli anni settanta,
- nel crollo del muro di Berlino (novembre 1989),
- negli scandali finanziari (in Italia legati all’indagine "Mani pulite"),
- nel crollo delle Torri Gemelle,
- nella recente e repentina mescolanza delle religioni e delle culture.
Cosa è veramente cambiato?
Il punto di sintesi è che nessuno oggi può avallare le sue idee semplicemente invocando il ruolo che riveste. Al posto dell’autorità sorge il tema della convinzione e la forma elementare della convivenza è quella della democrazia, cioè della libera determinazione del singolo.
Da qui l’indebolimento della forma territoriale della presenza ecclesiale, dettata dal diritto canonico, a favore di una presenza de vita di fede nei movimenti, nelle associazioni, nelle comunità di base. E nessuno ancora sa come mettere insieme i due sistemi, divenuti ormai quasi paralleli.
Si possono anche comprendere quei sentimenti di spaesamento e di precarietà che emergono in tutti i settori della vita.
Che cosa è reale oggi?
Quale nuovo ordine è sorto con l’arrivo delle nuove parole chiave dell’occidente: finitezza, alterità, tecnica, possibilità, democrazia?
Non è facile dirlo.
Resta in ogni caso un cambiamento, con tante conquiste, ma anche con grandi sfide davanti a sé.
Pur in mezzo a un innegabile progresso e ad un vacillante benessere, l’occidente deve fare i conti con il crescente tasso di denatalità, l’impensabile blocco della gioventù, la subordinazione cui sono ancora costrette le donne sul piano delle opportunità sociali, lavorative e politiche, la stagnazione economica, la questione del rapporto con il diverso e quindi la sua nuova identità.
Infine la sete di giustizia che brucia questo nostro mondo.
Come dovrà collocarsi la comunità dei credenti rispetto a tutto ciò?
3. Che cosa dobbiamo fare
Il compito del pensare teologico odierno deve consistere nell’assumere il ruolo di "mediatore" tra la storia (il tempo che ci è dato da vivere) e un vissuto cristiano che eviti la deriva dell’auto-referenzialità e della propria insistita particolarità.
Pur nella fatica e precarietà dell’impresa, ci deve sorreggere la convinzione che è stata espressa in modo convincente da Elmar Salmann : «La fede non si rifugia nel fondo uguale di un essere immutabile, ma si espone alle peripezie dei tempi con la scommessa che nessun’epoca è priva della grazia, al contrario, ognuna è una porta che si apre al mistero cristiano» .
Scommettiamo, allora, pascaliana¬mente su questo tempo.
Un tempo di povertà.
La comunità dei credenti non può arrendersi a questo tempo che la spoglia di tante sicurezze, in molti casi anche di sicurezze materiali:
- scarsità di vocazioni,
- poca gente a messa,
- fatica generale nella catechesi.
Questo è quello che è dato.
Tante for¬me di reazione a questa situazione non appaiono convincenti:
- voca¬zioni pescate all’estero;
- mobilitazioni di massa per dire che si è ancora tanti, ma che alla fine fanno sentire di più il vuoto del quotidiano parrocchiale;
- alleanze politiche assai discutibili, basate sull’archetipo maschile della condivisione del potere, che allontana dalla Chiesa i giovani e le donne;
- cambiamenti della pastorale affidati a documenti perfetti piuttosto che a piccole sperimentazioni guidate, effettive.
Serve, invece, il coraggio di riconoscere confessare la verità: la comunità dei credenti è diventata minoranza.
Solo da questo gesto può rinascere un atto di coraggio, di libertà, di signorilità.
Alla fine si tratta di resistenza.
Resistenza alla tentazione, oggi assai ricorrente, di ridurre il cristianesi¬mo a religione civile, svuotandolo così della sua forza profetica.
Resistenza alla sua progressiva museificazione ed ermeneutica infinita, che non lo rendono certo più significante.
In questa condizione di povertà e di conseguen¬te dimagrimento dell’apparato ecclesiale, si potrà finalmente sperimentare che cosa è fede e reale affidamento a quel Dio che in Gesù si è reso umanissimo compagno di viaggio.
Pur in mezzo a ogni grande povertà e spoliazione, non può essere tolto alla comunità dei credenti il suo bene più prezioso: Gesù, la sua santa umanità, riconci¬liata e riconciliante, liberata e liberante, benedetta e benedicente.
La povertà confessata, dunque, come tempo opportuno per riscoprire la forza magnetica di Gesù e per rinascere alla verità che egli è misura colma della vita.
E’ stato sempre lui la porta attraverso la quale sperare di poter vedere giorni felici.
Un tempo di estraneità.
Non può continuare, la comunità dei credenti, a fingere a se stessa con la solennità delle sue celebrazioni, con la fierezza dei suoi linguaggi, con lo stipendio di sacramenti, che il tempo aggiusterà ogni cosa.
Molti simboli cristiani «hanno perso il potere di trafiggere l’anima: di rendere inquieti, ansiosi, disperati, gioiosi, estatici, ricettivi nei confronti del significato» .
Eppure, la fede cristiana avrebbe una plasticità straordinaria!
Si pensi al salto dimensionale che i discepoli le fanno compiere dal parlato aramaico di Gesù al greco dei Vangeli. Si sono arresi alla non trasmissibilità dell’aramaico! Hanno rischiato, eccome. Ma non si sono fissati.
La traduzione culturale del cristianesimo occidentale oggi vigente, fortemente sacramentalista, gerarchica, sacrale, non regge più.
Ovviamente accettando, arrendendosi, senza risentimento a questa nuova forma di povertà: l’estraneità di un modello di cristianesimo, provando a salvarne il meglio.
Non è un bene, ma non è neppure il peggiore dei mali possibili.
Resistenza al rendere il cristianesimo una estetica, al renderlo un’esperienza individuale, nel senso di un’esperienza in cui il singolo decide della verità di ciò che viene annunciato, celebrato, vissuto.
Resistenza a una perdita di memoria della fede nelle nuove generazioni: se non si accetta che per loro è un fatto estraneo, si continuerà a occuparsi ossessivamente di morale, di dottrine sociali, di bioetica, mentre il cuore incandescente del cristianesimo resta in soffitta.
Partire dal riconoscimento di questa estraneità significherebbe invece che i credenti sono chiamati ad annunciare una novità.
Questa è una grande possibilità.
Qui ci vuole resistenza: il cristianesimo non è vecchio, non è passato, non è old.
La Chiesa, forse, sì! Duemila anni non sono pochi.
Ma la Bibbia e il Vangelo sono ancora ben lontani dall’avere esaurito la capacità di illuminare l’umano che è comune.
Un tempo di precarietà.
Tutto cambia molto velocemente.
Si è posti continuamente dinanzi a mutazioni politiche, economiche e sociali imprevedibili Si è raggiunti da tante notizie e sopraffatti dalle mille voci che entrano dentro il nostro spirito, inquietandolo.
Non c’è solo una precarietà lavorativa, finanziaria, c’e pure una precarietà dello spirito, che tocca in sorte a ciascuno.
In particolare, l’etica registra un’medita fatica nel fare i conti con le conquiste delle biotecnologie e con le grandi questioni legate al fine vita, al contenimento delle malattie sessualmente trasmissibili.
Possono sul serio i responsabili della comunità dei credenti ritenere di avere una parola decisiva per tutto?
Un’idea così vincolante da satu¬rare il lavoro del singolo?
Domande delicate, certo, e per questo vanno poste in punta di piedi, nella consapevolezza che non sempre la chiarezza delle norme e le norme della chiarezza possano risolvere ogni questione.
Si dovrebbe invece mettere più in rilievo la forza elevante, unifi¬cante che possiede il gesto della preghiera.
Con più generosità si dovrebbero offrire occasioni elementari di preghiera:
- nelle quali poter ritornare sulla verità del proprio essere e agire,
- nelle quali potersi ri¬conciliare con la bellezza del mondo e della vita, per pensare e per entrare in contatto con una presenza Altra e alta, con quella «luce gen¬tile», di cui parlò il beato J. H. Newman (1801-1890),
- occasioni per incontrare quel Dio ignoto ai più oggi, cui poter finalmente elevare una preghiera che sostenga il precario essere al mondo di ogni uomo e di ogni donna.
Un tempo di inattualità.
La comunità dei credenti deve accettare, arrendendosi, che non è più di moda la religione cristiana.
Per la maggior parte della gente, "quelli della Chiesa" cercano e propongo¬no cose vecchie, fuori moda, fuori gusto, fuori del mondo.
Ane¬lano a cose fuori del mondo.
Il paradiso, per esempio.
Sono gli ultimi, i credenti, a essere convinti che esso non sia nel mondo, né che sia il mondo.
Il paradiso invece è qui, su questa terra, e si chiama giovinez-za.
Chi la possiede, nulla gli manca.
Al centro dell’attuale condiviso immaginario vi è il culto e il mito della giovinezza.
Nessuno e interes¬sato alla vecchiaia, alla morte.
Si vuole vita, vita piena, vita giovane da qui un continuo vivere "contromano".
La fede cristiana e inattuale!
Fissa lo sguardo dove nessuno guarda.
Lo debbono sapere questo, i cristiani non solo sono estranei, sono inattuali. Debbono sapere di questa resistenza alla loro parola circa la verità e il destino della vita. Debbono arrendersi a questa resistenza, per poter sperare di resistere a essa. La ricerca della giovinezza oggi è ossessiva: nessun occidentale desidera diventare adulto, meno che mai vecchio.
La parola "vecchiaia" è scomparsa pure da Wikipedia, la grande enciclopedia di internet.
La Chiesa continua a chiamare i suoi ministri "preti", alla lettera: vecchi!
L’atteggiamento giusto è quello della resistenza, non quello del risentimento!
Si deve resistere anche alla dissoluzione del paradiso nella giovinezza.
Un minimo di platonismo è qui necessario alla religione cristiana: il finito non regge alle sue pretese. Ha bisogno di una forza che da se stesso non sa darsi. Senza la misura del paradiso, si perde la misura del finito, del mondo, della sua contingenza, della sua ricchezza e della sua positiva limitatezza.
Ecco allora il dispiegarsi di una feconda inattualità del cristianesi¬mo, di una sua conveniente estraneità: la sua denuncia decisa, profetica, che questo mondo non è il paradiso, ma che il paradiso esiste e si deve immaginare là dove esso sta.
Per questo si può amare anche l’età adul¬ta, si può accogliere senza risentimento e rancore l’invecchiamento, la malattia e la morte.
Si può essere liberi di non essere giovani e di passare ad altri il testimone della vita.
Un tempo di debolezza.
Va riconosciuto che la chiesa non è più al centro del mondo, della socie¬tà e dell’immaginario diffuso.
La chiesa non è più nella cabina della regia della storia.
Nessuno quasi attende più da essa il via libera per alcunché.
Non ha senso far finta di nulla e stare in attesa che le cose ritornino come prima.
La sua situazione di debolezza nei rapporti con la società, con le forze politiche, con l’avanzare delle nuove minoranze va accettata.
Un passo indietro farebbe bene.
Si torni alla verità dell’essere chiesa: luogo dove ci si trova a far festa per un Dio che ha un debole per l’uomo. Questa è la vera debo¬lezza della fede. Si torni a una chiesa della festa, esperienza antropo¬logica centrale, che permette all’uomo e alla donna di resistere alle schiavitù, alle idolatrie, alla depressione strisciante che da ogni dove oggi li tenta.
Un uomo, una donna capaci di far festa sono un uomo e una donna liberi, capaci di un debole per la vita, capaci di un debole per l’altro.
In un’intervista del 2011 al quotidiano «Avvenire», Jùrgen Moltmann (n. 1926) ha affermato: «Già troppo a lungo la gente ha relegato il cristianesimo nell’angolo della fede per proseguire indisturbata la secolarizzazione. E’ tempo che la fede cristiana esca dall’angolo: Cristo non ha fondato una nuova religione, ma ha portato una vita nuova!».
Questo forse è il tempo opportuno per prendere sul serio tale provocazione.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)